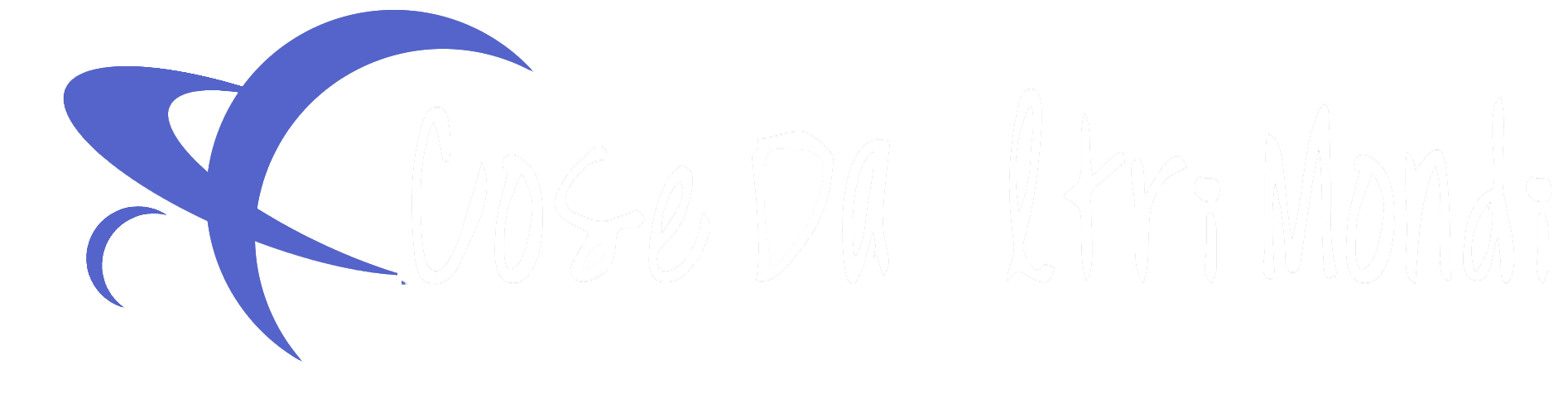TERAPIA VIRTUALE, DI GIOVANNA REPETTO

La copertina è World © di Roberta Guardascione
disegnata appositamente per Cose da Altri mondi.
Scelti dal Direttore
Il ragazzo emette un breve sospiro.
“Ho paura.”
Ha già indossato la tuta, manca solo il casco.
Anch’io ho indossato la tuta. Stiamo aspettando che i tecnici finiscano di allacciare i collegamenti.
Gli strizzo l’occhio.
“Anch’io.”
Non sto barando. È la prima volta, da quando lavoro al Servizio, che mi preparo a effettuare una seduta di Terapia Virtuale.
Stamattina, arrivando al lavoro, avevo già il batticuore. Sulla soglia stavo per inciampare in un gattino di pochi mesi, che si aggirava per gli scalini, uno dei soliti trovatelli da piazzare presso una persona di buona volontà. Alla fine si trova sempre qualcuno, un operatore o un utente del Servizio, o magari un rappresentante di medicinali capitato al momento giusto.
Zia Giovanna bighellonava nell’atrio, fumando il suo sigaro puzzolente con aria trasognata.
“Ho paura” le ho detto a mo’ di saluto.
Zia Giovanna è la psicologa anziana, quella che fa da supervisore alle mie terapie. Anziana è dir poco. Ha sulle spalle una ventina d’anni di lavoro al Servizio per le Tossicodipendenze, pare che nessuno sia mai sopravvissuto a tanto. La chiamano anche l’inossidabile, e forse non ho ancora scoperto tutte le ragioni di quel soprannome, anche se ne conosco almeno un paio.
Mi ha risposto con un mezzo sorriso.
“Non è che ti serve un gatto, per caso?”
Ecco, lei è fatta così. Tu te la stai facendo sotto e hai le gambe che ti tremano, e lei continua a fumare il suo fottuto sigaro e a pensare al fottuto gatto come se fosse la cosa più importante del mondo.
Ma aveva sentito benissimo. Infatti ha accentuato il sorriso e finalmente ha dato segno di accorgersi della mia espressione.
“Hai paura, lo so. È sempre un buon punto di partenza.”
“Che cosa vuoi dire?”
Mi stavo arrabbiando.
“Sarei preoccupata se non ne avessi.”
Ci siamo prese il caffè. Non mi sentivo molto confortata.
Il ragazzo ha corti ricci scuri e occhi neri lucenti. Sono occhi che ridono e cantano, quando tutto va per il meglio. Ma adesso no, riconosco la patina opaca che li offusca, come un velo di stanchezza. Eppure lo sguardo è vigile, la disintossicazione è stata portata a termine.
Ha paura. Credo di immaginare quello che prova. Penso a un animale abituato a muoversi nella foresta, nascondendosi fra gli alberi, in un ambiente noto: e poi qualcuno ha abbattuto tutte le piante, e lui si sente scoperto, senza difese.
Gli sorrido. Mi rimanda il sorriso con espressione infantile, di attesa. Aspetta Babbo Natale, penso, ma ha una mezza idea che il sacco sarà pieno di carbone.
“Ci siamo” dico “è il momento che aspettavi, no?”
Annuisce poco convinto. E d’altronde anch’io sento una morsa allo stomaco.
L’équipe di supervisione ha già preso posto. Zia Giovanna ha spento il sigaro per l’occasione, e sta parlando sottovoce con il nuovo operatore. Si chiama Franco.
L’ho conosciuto stamattina. Allampanato e magro come una frusta, un fascio di nervi. Dietro le lenti spesse gli occhi dardeggiano come capocchie di spillo, la bocca serpeggia ironica. Non ho fatto in tempo a sapere niente di lui, ma pare che d’ora in avanti lavorerà qui.
Zia Giovanna lo conosceva già. Quando è entrato si sono praticamente saltati al collo, abbracciandosi e baciandosi sulle guance. Forse un ex collega, ho pensato. Ma c’è qualcosa di più. Un legame particolare, di cui non capisco l’esatta natura. Non che ci sia una storia fra i due. Zia Giovanna è troppo stagionata per lui, e poi si capisce che è una cosa diversa. Sembrano parenti, ma non è nemmeno quello. Lei se lo mangia con gli occhi, con uno sguardo umido che non le è abituale.
I tecnici ci aiutano a infilare il casco. Supero con pazienza il primo impatto claustrofobico. Cerco di rincuorarmi pensando all’équipe che ci assiste. Sui loro monitor seguiranno la nostra avventura virtuale, completa di tutti i parametri delle funzioni vitali: frequenza cardiaca, pressione, e così via. Il medico di turno avrà di che spassarsela.
Non riesco ancora a vedere niente. Allungo una mano, sento che il ragazzo è vicino a me.
“Dove ci troviamo?” gli chiedo.
Sarà lui a proiettare un’immagine mentale. Io mi sforzo di non pensare a niente, per non interferire.
Qualcosa di nebuloso emerge dalla sua mente, si distribuisce intorno a noi, prende forma. È il luogo della sua anima, il suo paesaggio interiore, una metafora tridimensionale. Quasi mi sfugge un urlo.
“Cristo!”
So che dovrei essere più professionale, ma vorrei vedere qualcun altro al mio posto.
Siamo abbarbicati su un dirupo. Intorno non ci sono che rocce a picco, terra brulla e riarsa, pietre franate sotto un cielo plumbeo. Cerco di assumere un tono più normale.
“Pare che non ci sia granché, vero?”
Il ragazzo emette una specie di grugnito, quasi un gemito.
“Lo vedi perché ho bisogno di essere sempre sconvolto? Non riesco a sopportare tutto questo, senza la roba.”
Man mano mi sto rinfrancando, perché so di avere la risposta già pronta.
“È proprio la roba” dico “che ha bruciato tutto così. Magari prima c’era un bel prato, e se tu dessi all’erba il tempo di ricrescere…”
In un angolo del cielo lampeggia una luce gialla. È un messaggio della supervisione. Le parole si stagliano contro le nuvole. In realtà sono nel mio schermo, e solo io posso vederle.
SMETTILA DI PERDERTI IN CHIACCHIERE
QUESTE MENATE LE HA GIÀ SENTITE CENTO VOLTE
È lo stile di Zia Giovanna, mi sembra quasi di sentire tutta la soavità della sua voce.
Mi rivolgo al ragazzo.
“Non c’è un altro posto dove possiamo andare?”
Lui si guarda attorno smarrito, indeciso. Lo sento così scoraggiato che temo voglia interrompere subito l’esperienza.
Poi mi indica un punto con la mano.
“C’è qualcosa, là.”
In lontananza, ma così lontano che sembra un altro pianeta, si delinea un paesaggio sfumato, non privo di bellezza. Forse è un ricordo infantile, forse una speranza. Un puntolino, ma è sempre qualcosa.
“Bene” dico “è magnifico!”
Mi accorgo di aver esagerato il tono entusiastico, a rischio di essere poco credibile.
“Certo, è lontano” aggiungo con voce più dimessa “ma ci sarà bene un modo per arrivarci.”
Il ragazzo risponde bruscamente.
“Non c’è.”
“Forse dobbiamo guardare meglio. Con un po’ di pazienza.”
“Non c’è la strada. Non si può far niente.”
Sembra che abbia fretta di liquidare la faccenda.
Un’altra striscia gialla lampeggia.
LO STAI PERDENDO
Caso mai non l’avessi capito.
“Come stai?” gli domando.
“Sto male.”
“Male come?”
“Male.”
Mi domando se non ci sia qualche problema fisico. La supervisione mi viene in aiuto. Dev’essere il medico. Si nota qualche sintomo di astinenza, dice, ma è probabilmente dovuto a suggestione.
Mi avvicino, gli stringo la mano, il braccio.
“Credo che sia la paura” dico.
“Voglio andarmene.”
“Hai ragione, questo è un postaccio. Fa paura anche a me.”
“Voglio andare.”
“Ce ne andiamo insieme, no?”
Ride nervosamente.
“Vuoi seguirmi?”
“No, non dove pensi tu. Ci dev’essere un’altra strada.”
“Non la vedo.”
“Non aver fretta. Prendiamoci un po’ di tempo.”
Mi accoccolo sulla roccia, sfruttando uno spigolo sporgente. Esita, poi fa la stessa cosa.
“E adesso?”
“È già importante imparare a far questo” dico “prendere tempo per riflettere, prima di precipitare le cose. Ora lo stiamo facendo. È una cosa che si può fare, no?”
Sui nuvoloni bluastri lampeggia una scritta verde fosforescente.
BENE COSÌ
Il ragazzo si guarda attorno perplesso.
“Qui è tutta una rovina.”
In effetti il paesaggio dà un senso di desolazione assoluta. Le rocce sono spezzate come denti guasti, le scarpate sono ghiaioni ingombri di ogni sorta di detriti. Nei rari punti in cui potrebbe aprirsi un sentiero, cumuli di macerie ostruiscono la visuale.
“Possiamo provare a camminare. Il terreno è accidentato, ma andremo lentamente.”
“Non si può, qui frana tutto.”
Posso immaginare che cosa siano tutti quei sassi: brutte esperienze, fallimenti, sensi di colpa, occasioni perdute.
“C’è almeno un punto solido?”
Il suo sguardo si posa su un pezzetto di cengia che sporge poco sopra di noi dalla parete rocciosa. Non so che cosa rappresenti nel suo universo interiore, ma sembra una buona pista.
Ci muoviamo risalendo il ghiaione che frana sotto i piedi.
A un tratto scivolo di brutto, lui mi trattiene per un braccio, mi solleva, mi tira verso di sé finché non sento i piedi al sicuro.
“Ehi, sei forte!” dico, in tono di sincera ammirazione.
“Mi stai prendendo in giro?”
Ansima leggermente.
“No, mi hai stupita davvero. Sei più forte di quel che sembra.”
“È solo che stavo ben appoggiato con i piedi.”
Ridacchio.
“Penso che tu sia più forte di quanto vuoi credere di essere.”
Sbuffa.
“E allora perché non riesco a uscirne?”
“Intanto sei riuscito a sopravvivere in questo cazzo di posto. Non scherzo, non è cosa da poco.”
Scuote la testa, ma riprende a camminare.
Sulla cengia muoviamo pochi passi, prima di imbatterci in un cumulo di detriti.
“Fine della corsa!” esclama con cupa ironia.
“Perché?”
“Non vedi, non c’è più sentiero.”
“C’è, ma sta sotto i sassi.”
“Non vorrai mica spostare tutte queste macerie?”
“Vedo solo due possibilità: toglierle o passarci sopra.”
Il ragazzo alza le spalle.
“È tutto inutile. Quel posto è troppo lontano. Da qui non si vede neanche.”
Allude al paesaggio che avevamo visualizzato in lontananza. In effetti era proprio un barlume, forse un miraggio. Tuttavia provo a bluffare.
“Non è vero, non è lontano, e dev’essere bellissimo.”
La luce gialla lampeggia.
NON RACCONTARE BALLE
Mi correggo.
“Sì, è lontano, chissà dove. Ma abbiamo la strada. È qui, sotto i nostri occhi. Facciamo una cosa alla volta. Concentriamoci sulla strada.”
Di passare sulla frana non se ne parla: i sassi rotolano sotto i piedi, fanno perdere l’equilibrio. Cominciamo a spostarli con le mani. Non sono molto pesanti, ma sembrano gommosi, viscidi, quasi attaccaticci.
Man mano che il sentiero si libera, il ragazzo sembra sollevato. Lo incoraggio.
“Stiamo procedendo bene, non ti pare?”
Sorride.
“Sai che quasi mi piace fare questo lavoro?”
Mi sento soddisfatta, e credo che lo sia anche Zia Giovanna, dal suo punto di osservazione.
Appena il sentiero è abbastanza libero, ci muoviamo. È una cengia piuttosto stretta che percorre il fianco della montagna. Con una mano ci appoggiamo alla parete rocciosa, procedendo uno dietro l’altro.
Poi il sentiero gira intorno alla roccia, svoltando su un nuovo panorama.
È qui che mi si piegano le gambe.
Quello che si apre sotto di noi non è una valle, e nemmeno un burrone. È semplicemente un baratro, di cui non si distingue il fondo.
Mi stringo con la schiena contro la roccia, cercando di prendere respiro. Il ragazzo è immobile, come congelato.
L’abisso è così profondo che dentro potrebbe esserci qualunque cosa: acqua, terra, non è possibile vedere. Le pareti si perdono in un’oscurità minacciosa.
È l’angoscia, penso. Un’angoscia esistenziale, profonda, insondabile. Un vuoto da vertigini.
Quel che è peggio, non so che cosa fare. Non mi viene in mente nessuna cosa sensata da dire.
Siamo paralizzati in due.
La luce gialla arriva puntualmente, a ricordarmi che devo muovermi.
Mi rivolgo al ragazzo, indicando il baratro.
“Che cos’è questo? Sai dargli un nome?”
Scuote violentemente il capo.
“L’hai visto altre volte?”
Mi accorgo che è una domanda stupida. Certamente conosce bene quella configurazione, anche se non l’ha mai visualizzata come paesaggio virtuale. Ma lui capisce al volo.
“È sempre stato così” mormora in un singulto “anche prima… anche prima della roba.”
Penso che sta davvero messo male. Mi blocco di nuovo.
HO VISTO DI PEGGIO
PROSEGUI
Zia Giovanna ha colpito ancora, proprio mentre temevo di dover tornare indietro. Tutto sommato mi conforta l’idea che esista un modo per proseguire. Peccato che nessuno mi dica quale.
Cerco di rilassarmi, di abbandonarmi alla corrente empatica.
“Ti sei portato dentro questa cosa per tanto tempo, senza riuscire ad affrontarla…”
“Come potevo?”
“No, da solo non avresti potuto, credo. E devi aver sofferto parecchio.”
“Anche adesso non sto tanto bene” puntualizza con ironia.
“Sì, ci credo.”
Emette un sospiro stanco.
“Che cosa dobbiamo fare?”
A questo punto vorrei poterlo confortare con un caffè, un tè caldo, o magari un sigaro di Zia Giovanna. Invece siamo intrappolati in questo paesaggio del cavolo. Gli metto una mano sulla spalla.
“Intanto siamo in due” dico.
Ride amaramente.
“Io sono quasi sempre in due.”
Vorrei che non lo avesse detto. So che allude alla roba.
“Siamo due persone!” ribatto con rabbia.
Alza le spalle.
“Così torniamo indietro in due.”
Chiedo: “Eri mai stato qui così a lungo?”
“Vuoi sapere se ho mai guardato questo posto da lucido?”
“Ecco, appunto.”
“Forse no, non così. Mi sono sempre sconvolto prima.”
“Allora è la prima volta che guardi davvero.”
Un lampeggiamento verde mi dice che sto procedendo bene.
“Sì” risponde il ragazzo “ma non è un gran bel vedere.”
“Lo so, non piacerebbe a nessuno. Ma intanto sei stato capace di guardare. Una cosa che non avevi mai fatto prima.”
“A che serve? Non è che a forza di guardare possiamo arrivare di là.”
Indica un punto con la mano, sulla montagna di fronte, oltre l’abisso. È la solita oasi, ma ora si vede più nitida e splendente.
“Ehi! Ma allora la vedi sempre!”
Fa spallucce.
Sembra che la profondità dell’abisso e la luminosità della meta si esaltino a vicenda. Questo contrasto dev’essere una buona parte del problema. L’impotenza contrapposta al livello di aspirazione.
“Ti piacerebbe arrivarci?”
Una scritta gialla mi mette in guardia.
PROBABILMENTE È UNA META ILLUSORIA
TROVA QUALCOSA DI PIÙ’ VICINO
“Che cosa?” brontolo fra i denti “Una stella alpina?”
Il ragazzo intanto sta rispondendo con un certo sarcasmo alla mia domanda.
“Tu credi di potermi aiutare?”
So che devo essere sincera.
“Non so se ne sono capace.”
“Andiamo bene!”
“Ma non siamo soli. E intanto siamo arrivati fin qui.”
“Per quello che serve!”
La scritta lampeggia in verde.
CONTINUA CON IL RINFORZO
“Abbiamo fatto un bel pezzo di strada. E hai imparato che sei capace di fare alcune cose che non credevi possibili. Sei riuscito a non tornare subito indietro, ad aspettare, a riflettere. Hai superato degli ostacoli. Hai guardato qualcosa che non volevi vedere.”
“Sarà…”
“Hai imparato che esiste un percorso.”
“Sì, ma si ferma qui.”
“Non penserai che si risolva tutto in una volta!”
Bisogna sconfiggere la logica del tutto e subito, come dice Zia Giovanna: la logica della roba.
Il ragazzo si gratta la testa, con una smorfia.
“Quell’altro pezzo però è troppo difficile.”
“Quale pezzo?”
“Quello.”
Indica qualcosa. Seguo la direzione con lo sguardo e rimango a bocca aperta.
Una linea dritta e sottile si staglia sopra il baratro, unendo le due sponde. Un ponte!
“L’hai trovato…” non sto nella pelle “capisci cosa vuol dire? Hai trovato un passaggio!”
Lui scuote la testa con forza.
“Non è possibile… Nessuno potrebbe passare là sopra.”
“Proviamo. È un ponte, non vedi? Procediamo piano, uno dietro l’altro. Possiamo farcela.”
“Voglio tornare indietro.”
Sto per ribattere, quando una scritta gialla lampeggia contro la roccia.
HA RAGIONE
LA SEDUTA È DURATA ABBASTANZA
LASCIA IL PONTE PER LA PROSSIMA VOLTA
Quel consiglio mi suscita un senso di ribellione. Penso che si debba battere il ferro finché è caldo.
“Non credo che si debba perdere quest’occasione” dico ad alta voce.
“Ho paura” mormora il ragazzo.
Quella frase mi smuove dentro qualcosa: lo sento come un cucciolo indifeso, che io posso proteggere, guidare.
Lo prendo per mano, tirandolo dolcemente. Mi sento forte. Sento che posso farcela.
La luce gialla ricompare.
HAI UNA BELLA SCARICA DI ADRENALINA
È UN ATTACCO DI ONNIPOTENZA
“La strada c’è” dico “e non sono stata io a trovarla.”
Zia Giovanna fa sempre grandi discorsi, sui rischi dell’onnipotenza e su quelli dell’impotenza. Dice che la via d’uscita è il realismo. Ma quel ponte è reale, perdio!
Mi volto verso il ragazzo.
“Decidi tu. Vuoi perdere quest’occasione, o preferisci…”
LO STAI RICATTANDO
Cambio registro.
“Possiamo tornare indietro e riprovare la prossima volta. Ma io sento che potremmo farcela adesso.”
Esita.
“Ti terrò per mano” aggiungo.
“Va bene…”
Lo dice senza enfasi, come per farmi piacere. Ma a me basta.
Respiro profondamente. Mi viene in mente quello spilungone che è arrivato oggi, il nuovo operatore che sta in sala di supervisione. Credo che finora queste cose le abbia lette solo nei libri, e immagino che vederle dal vivo debba fargli una certa impressione. Mi sembra di vederlo con gli occhi spalancati, ad ammirare la mia sagacia e il mio coraggio.
“Desidero proseguire” dico rivolta soprattutto alla supervisione.
La scritta gialla che compare mi suona beffarda.
IN BOCCA AL LUPO
Stringo forte la mano del ragazzo, lo guido fino all’inizio del ponte.
È davvero stretto.
“Vai avanti tu” gli dico “così controllo dove metti i piedi.”
Al primo passo incespica, smuove un sasso che rotola giù per il burrone. Vederlo cadere dà le vertigini.
Alla fine si sente un plof, dev’esserci dell’acqua, laggiù. Infatti ora si vedono baluginare dei riflessi, si forma un’immagine che aleggia nell’ombra. Sembra un volto di donna deformato. Forse la distorsione di un’immagine materna, legata a ricordi angosciosi.
Il ragazzo la guarda agghiacciato. Si irrigidisce.
“Non guardare giù. Non adesso. Quando saremo dall’altra parte avremo tutto il tempo per cercare di capire.”
Si muove docilmente, guardando avanti, un passo alla volta. Lo seguo da vicino, con le mani allungate in avanti ai lati del suo corpo, così da sfiorargli le spalle, le braccia, i gomiti.
“Va bene così” gli dico. Lo incoraggio continuamente con la voce.
Cerco anch’io di non guardarmi intorno, e tanto meno in basso, di concentrarmi solo sull’atto del camminare.
Procediamo molto lentamente, tanto più che un vento contrario aumenta la fatica di ogni passo. Non capisco che cosa rappresenti, ma dà fastidio. Sento nei muscoli una tensione dolorosa.
Non so da quanto sia cominciato, ma solo ora divento consapevole di un brontolio sordo, una specie di vibrazione. Potrebbe essere un tuono, se non si trattasse di un rumore costante, in graduale aumento. Una scritta gialla dalla supervisione conferma la mia percezione.
C’È QUALCOSA NELL’ARIA
STA’ ATTENTA
Il brontolio ha un tono minaccioso. Provo un’acuta sensazione di pericolo.
“Come va?” chiedo.
Il ragazzo non risponde, ma i suoi passi ora sembrano più incerti. Sta rallentando.
Il brontolio aumenta, diventa rumore e suono, si articola in una cupa armonia. Ora è una musica che fa accapponare la pelle.
Il ragazzo si è fermato e guarda in basso. Sembra affascinato.
“Non guardare, ti prego.”
Non mi ascolta, è come assorto in un’altra realtà.
Non posso fare a meno di guardare anch’io. Qualcosa si muove, nell’abisso. Pulsa al ritmo ipnotico della musica. È qualcosa di incredibilmente morbido, con sinuosità da ragno. È un orrore felpato e seducente.
L’intuizione si fa strada già mentre formulo la domanda.
“Che cosa diavolo è?”
La scritta gialla è di un sarcasmo crudele.
HAI MAI SENTITO PARLARE DELLA ROBA?
A volte vorrei che Zia Giovanna si spegnesse il sigaro fra le chiappe e si zittisse definitivamente.
Però ha ragione. Come ho fatto a non pensare che la maledetta doveva per forza essersi scavata una tana proprio là, nel profondo dell’angoscia?
È lì che lo aspetta, e io l’ho portato tranquillamente nella trappola.
Afferro il ragazzo per le braccia. Cerco di tenerlo saldamente.
Ricompare la luce gialla.
COINVOLGIMENTO VICINO AL LIMITE
So che rischio di coinvolgermi troppo, ma non voglio perderlo.
Il ragazzo si sta sporgendo verso il basso, come attratto da una calamita. Lo sforzo di trattenerlo mi fa dolere le braccia. Gli parlo, ma non mi ascolta.
L’HAI GIÀ PERSO
LASCIALO ANDARE
Aumento la stretta. Come posso rinunciare adesso? Lui si divincola, lo trattengo con tutte le mie forze. Non riesco a staccarmi da lui. L’ho portato fin qui, devo tenerlo.
LASCIALO ANDARE
La cosa striscia sul fondo, riempiendo l’aria della sua musica infernale. Ho smesso di pensare. Tutta la mia forza è concentrata nelle mani.
Il ragazzo si lancia in avanti. Io non mollo la stretta, mi sento tirare, perdo l’equilibrio, cado bocconi sulla superficie del ponte.
Ora la mia posizione è incresciosa. Sto distesa sul ponte a pancia in giù, trattenendo con le mani il ragazzo che scalcia nel vuoto. Non potrò reggere a lungo.
Questa volta la scritta è rosso fuoco.
INVISCHIAMENTO!
Capisco che sono in pericolo, ma è come se la mia sorte ora fosse indissolubilmente legata a quella del ragazzo.
INVISCHIAMENTO!
Se io cado là dentro è un brutto guaio. No, non rischio l’abbraccio del mostro. Non ho mai conosciuto la roba, e per fortuna non so cosa mi perdo. Ma quell’abisso… è angoscia allo stato puro, perdio!
INVISCHIAMENTO!
Oltre alla scritta adesso c’è un ronzio intermittente, un segnale d’allarme. In supervisione devono essere in subbuglio, ma non possono essere loro a interrompere la seduta, pena guai peggiori. Immagino Zia Giovanna che digrigna bestemmie dietro il sigaro spento.
La mia testa sporge vertiginosamente sul vuoto, ho lo stomaco sottosopra. Mi sforzo di pensare a come potrei trovare un punto d’appoggio per tirare su il ragazzo.
Se io cado sarà un problema anche per lui. Un altro senso di colpa. Se io cado…
INVISCHIAMENTO!
Sento che le mani del ragazzo non si sforzano di stringere le mie, anzi cercano di sgusciare. Mi apro alla consapevolezza che la volontà di tenerlo è mia soltanto. Lui vuole cadere.
L’intuizione mi riempie la mente: non posso volere una cosa per tutti e due.
Le mie mani allentano la stretta, si aprono come frutti di mare vinti dal fuoco.
Il ragazzo cade senza un grido. Lo seguo con gli occhi finché non scompare alla vista. Nell’atto di inghiottirlo, il baratro sembra emettere uno schiocco osceno.
Mi distendo sulla schiena, consapevole solo del fatto che sto respirando.
Gli occhi, chiusi, sembrano pieni di aghi di ghiaccio che non vogliono sciogliersi. Sento che intorno il paesaggio è scomparso.
Qualcuno mi sta toccando. Mi aiutano a sfilare il casco e la tuta.
“Fate piano” bofonchio aprendo gli occhi. Mi sento come se mi avessero lavorata con una schiacciasassi.
Il ragazzo, al contrario, è già sgusciato agilmente fuori dall’armamentario. Sfugge il mio sguardo. Borbotta: “Grazie, tornerò domani.”
Il sorriso di circostanza non basta a mascherare la voglia di scappar via. Lo spacciatore lo aspetta poco lontano.
Qualcuno mi getta addosso uno scialle, perché sto tremando. Mi porgono una tazza di tè caldo.
“Avevi una discreta tachicardia” osserva il medico.
Zia Giovanna mi strofina le braccia, un gesto a metà fra la carezza e il massaggio.
“Come stai?”
Quasi non oso guardarla, tanta è la vergogna.
“Di merda.”
“È naturale” dice Franco, il nuovo operatore.
Incrocio il suo sguardo affettuosamente ironico. Ma lui che c’entra?
“Sei stata abbastanza brava” dice Zia Giovanna.
Le spalanco gli occhi in faccia, quasi offesa.
“Brava? Mi stai prendendo in giro?”
Senza volere, ho usato le stesse parole del ragazzo.
Lei ha riacceso il sigaro.
“Dopo tutto è la prima volta, no?”
“Voglio cambiare lavoro” rispondo cupa.
Tutti ridono.
“Dicevo sempre così all’inizio” ricorda Zia Giovanna.
“Ho fatto un disastro” dico.
“Hai fatto un tentativo, e hai sperimentato i tuoi limiti.”
“Ma non è giusto che io lo faccia sulla pelle dei pazienti.”
“Non sopravvalutare l’entità del danno. Spesso loro hanno più risorse di quelle che siamo portati ad attribuirgli. Alcuni di loro, a furia di cercare la morte, hanno sviluppato una tenace propensione a sopravvivere.”
Così dicendo, Zia Giovanna strizza l’occhio a Franco, che ridacchia.
Mi massaggio le reni indolenzite. Non c’è muscolo che non mi faccia male.
“Non tornerà” sospiro.
“Dagli tempo” aspira una boccata di fumo. “E danne anche a te stessa.”
Franco si piega verso di me, mi sfiora leggermente la mano, come a richiamare la mia attenzione. Mi rivolge uno sguardo penetrante.
“Il ragazzo non era pronto.”
Pronuncia le parole lentamente, con una strana sicurezza. Che cosa ne sa?
“Non era pronto” ripete “ma tornerà.”
Per essere un nuovo arrivato, mi sembra un po’ saputello.
“Come fai a saperlo?”
Lo sguardo guizza divertito, la bocca si piega con malizia.
“Io stavo come lui.”
Gusta la mia sorpresa, prima di aggiungere: “Forse peggio di lui, quando sono entrato qui per la prima volta.”
Di colpo tutto mi si fa chiaro, i pezzi combaciano. Soprattutto capisco la natura del legame che lo unisce a Zia Giovanna.
La mia disavventura ora mi sembra meno tragica.
Zia Giovanna rimugina assorta. Poi, seria, si rivolge a Franco.
“A proposito, non è che per caso ti serve un gatto?”
Questo racconto è World © di Giovanna Repetto. All rights reserved
Giovanna Repetto
Nata a Genova, vive e lavora a Roma. La fantascienza è sempre stata la sua passione. Finalista al Premio Urania, la prima con "Il Nastro di Sanchez." I suoi racconti sono presenti in pubblicazioni italiane e straniere. "La Legge della penombra" ha vinto il premio Short Kipple; nel 2018. Il suo romanzo è "Icarus."