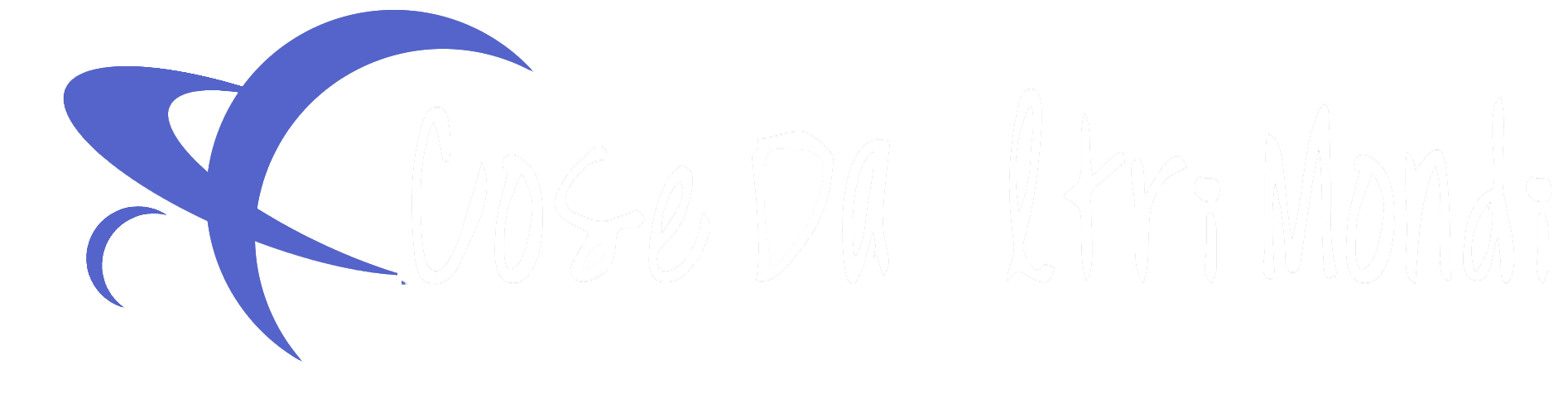L’INDETERMINAZIONE DEL FANTASTICO OGGI

Il fantastico secondo Heisenberg
(1993-1994)
Recentemente una persona poco incline a guardare il mondo anche in chiave fantastica mi pose la classica domanda, quella che prima o poi viene posta a tutti coloro che trattano le dimensioni del fantastico, e cioè: come si fa ad immaginare certe cose?
L’altrettanto classica risposta di lasciar lavorare la fantasia e coordinare poi i vari elementi agganciandoli a parametri logici, questa volta mi fece riflettere. Siamo abituati a dare risposte che per noi sono ovvie ma che lo sono molto meno per coloro i quali vivono le dimensioni del fantastico solo attraverso input esterni e sono costretti ad apprenderle, nel senso di strumento, come qualsiasi altro bene di cui non sono forniti naturalmente.
Chi invece fa parte degli addetti ai lavori convive con il fantastico, lo considera parte integrante del quotidiano come possono esserlo il sonno e l’alimentazione o il lavoro.
C’è una vasta gamma di valutazioni che collocano il fantastico entro limiti che vanno da ragione di vita a fastidioso impedimento per la realizzazione del razionale. Indipendentemente da ciò, resta il fatto che la componente fantastica rientra nella nostra cultura, fa parte di noi e, anche se inconsciamente, determina le nostre attività. A volte entra d’autorità nel tessuto esistenziale attraverso il sogno il quale, non dimentichiamolo, prende con il sonno buona parte della nostra vita, presentandoci con una logica illogica che accettiamo in forma acritica sia dal punto dell’archetipo junghiano sia a livello individuale.
Una recente teoria, dissociandosi dalla concezione freudiana, vede nel meccanismo onirico il rafforzamento dei caratteri ereditari, il mantenimento dell’equilibrio genetico e, conseguentemente, l’integrità psicofisica nella lotta del quotidiano cosciente.
Sappiamo che in situazioni in cui vengono somministrati farmaci oniro inibitori si verifica un’attenuazione delle caratteristiche individuali e uno spostamento nella direzione individuo/uomo-massa relativamente al pensiero e alla partecipazione al conformismo ambientale, a conferma che il fantasticare non interessa solo l’allargamento e la liberazione del proprio Io, ma anche il mantenimento della propria identità.
Un’altra teoria ridurrebbe il sogno a mere reazioni biochimiche casuali, con la conseguenza che basterebbe un intervento di tipo chimico per modificarne il corso.
Probabilmente, lasciando ad un estremo le teorie freudiane/junghiane e all’altro quelle biochimiche enunciate da Allan Hobson, potremmo concordare con quanto afferma il professor Alberto Oliveiro, e cioè dire che durante il sonno onde elettriche colpiscono sì a casaccio le sedi nervose del nostro cervello, ma quest’ultimo associa tra loro le sensazioni lontane e/o recenti così risvegliate “costruendo” delle storie attraverso quella logica a cui accennavo prima. Insomma, pur dando credito alla tesi bio elettrochimica, la componente psicologica del sogno mantiene tutta la sua importanza, nulla togliendo al pensiero di Blaise Pascal quando disse che “un falegname che sogna tutte le notti di essere re è altrettanto felice di un re che sogna tutte le notti di essere un falegname.”
Comunque sia, mettendo da parte quelli che possono essere i meccanismi del sogno, esso rimane ciò che Michel Jouvet, lo scopritore del sogno-paradosso, definisce come il terzo stato del cervello. In media dedichiamo cento minuti ogni notte del nostro sonno a sognare. Un uomo, a 65 anni, ha vissuto quattro anni e mezzo nella illogicità logica delle dimensioni oniriche. Non possiamo non riconoscere l’importanza si questa componente. D’altra parte, l’aveva detto anche Shakespeare ne La Tempesta che siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni.
Immaginario e fantastico, quindi, come elementi di un ordine di base che regola la nostra presenza fisica nel reale quadridimensionale, dove la contraddizione in termini tra astrazione e pragma è solo apparente. L’impostazione del nostro quotidiano si basa sulla concretezza che ci circonda. Nella società attuale la materia prima che fornisce la misura della realtà è l’informazione nelle sue diverse forme. Siamo avvolti da informazioni che attraverso stampa, radio, televisione, cinema, pubblicità, si sommano e interagiscono creando il tessuto del concreto necessario per le nostre azioni presenti e future e, per loro mezzo, ci rendiamo consci del mondo nel quale e contro il quale dobbiamo combattere la nostra battaglia quotidiana.
Ora, questo milieu che costituisce la piattaforma su cui impostare le nostre azioni non corrisponde più alla realtà oggettiva perché si è collocato su un piano di indeterminatezza. Ogni giorno affrontiamo una commistione di realtà diverse che ci provoca incertezza, sospensione di credibilità, diffidenza e sospetto, dubbi esistenziali. La notizia che ascoltiamo alla radio di primo mattino viene modificata all’ora del break e ridimensionata o addirittura capovolta nell’edizione serale del telegiornale. Certe informazioni date dallo speaker vengono contemporaneamente smentite dai titoli che scorrono in sovrimpressione. Elementi di cronaca, economia, politica, scienza, assumono significati diversi a seconda della testata che li ospita nell’affannosa ricerca dello scoop, dell’esclusiva, dell’audience, e così l’informazione diventa fine a sé stessa indipendentemente dalla sua validità e correttezza: ci sarà sempre tempo per la rettifica che, tra l’altro, costituisce un singolare termometro della libertà di informazione (appena inaugurata la glasnost, anche Pravda e Isvestia cominciarono subito a rettificare).
Nel nostro Villaggio Globale dove tutto tende a essere conosciuto in tempo reale, basta la parola di un personaggio, un suo gesto o un suo silenzio perché essi siano interpretati e divulgati, è sufficiente un’intenzione perché essa si trasformi in fatto che a volte provoca effetti enantiomorfi. Negli Stati Uniti questi effetti vengono definiti self-unfulfilling prophecies, vale a dire avvenimenti imposti subitaneamente dai media che portano a effetti opposti.
Tutto si sta uniformando. Quello che un tempo veniva definito phisique du rôle, adesso non ha più significato poiché conta solo apparire, farsi un nome indipendentemente dall’operato, ribaltando così il concetto dell’artista medievale che non firmava la pietra in quanto si considerava mero strumento per trasmettere il messaggio. Parlando del programma Odiens Antonio Ricci ebbe a dire: “La tesi della trasmissione è che tutti, star, uomini della strada, animali, sono uguali. Bestie ammaestrate per comparire.”
Per quanto riguarda l’iconografia, una sofisticazione sempre più esasperata propone immagini che spaziano da una iper-realtà di frontiera (imprese tanto più stravaganti quanto più munifici sono gli sponsor che la finanziano) alla cronaca-spettacolo della hot-television americana dove vengono effettuate visite mediche e diagnosi in diretta, o dibattiti volutamente provocatori tanto da giungere, sempre in diretta, allo scontro fisico. Alcune infiltrazioni già le abbiamo sui teleschermi nostrani.
In quella che viene chiamata TV dell’evento, detta terra-terra “il bello della diretta”, il reale e la fiction si amalgamo diventando infotainment (da information e entertainment), cioè realtà e show. Durante la campagna presidenziale USA del 1988, il giornalista Pat Buchanan non riuscì a intervistare Michael Dukakis. Allora Buchanan costruì un’intervista con un attore sosia sulla base di un dibattito selezionato da un computer tra tutti i testi archiviati di Dukakis. La percentuale di telespettatori che non si accorsero della fiction fu elevatissima.
Da noi Giovanni Minoli fa parlare chi ha modificato i risultati del referendum che ha trasformato l’Italia in una repubblica, per poi dire che non è vero niente. I caduti di Timosoara erano cadaveri prelevati dagli ospedali e sistemati come comparse. Il comportamento e le espressioni dell’orso nel film omonimo di Annaud non erano che il risultato di addestramenti pavloviani. Eccetera.
Inseriti come siamo in questo magma di informazioni, di realtà fantastiche e di fantasie realistiche, la nostra giornata-tipo si sta trasformando in un videoclip di 24 ore, a ciò che viene definito “processo di desertificazione semantica”, una sorta di Babele elettronica dove i significati si annullano a vicenda, e inconsciamente avvertiamo l’annullamento del libero arbitrio perpetrato da schiere di image-maker, maître-à-penser, persuasori occulti che intervengono a priori in ogni nostra azione. Sempre più difficilmente individuiamo una certezza, un appiglio di realtà oggettiva a cui aggrapparci per stabilire le basi su cui impostare i nostri giudizi. In questa situazione ci troviamo a vivere in una indeterminatezza fra realtà e immaginario dove la realtà si è prostituita e disintegrata, spostata su dimensioni che non le appartengono, e l’immaginario viene usato per costruire una realtà bastarda. Ormai il principio secondo il quale il commento è libero e l’informazione sacra non ha più significato.
Per lavorare sul futuro dobbiamo basarci su dati storici i quali ci forniscono gli elementi necessari per le estrapolazioni, le proiezioni, i budget. Più dati concreti avremo, maggiori garanzie ci saranno per soddisfare la previsione. In realtà, i cosiddetti “processi non lineari” e “varianti anomale” aumentano sempre di più. Già di per sé sarebbe impossibile fare previsioni in quanto si lavora sul tempo che è per definizione imprevedibile: la minima variazione in un luogo qualsiasi può causare enormi conseguenze, quello che viene definito “effetto farfalla” (il battito d’ali di una farfalla a Pechino può provocare un leggero alito il quale, a poco a poco, diventerà un uragano che si scatenerà sulla California).
Quindi alla difficoltà naturale di previsione vengono aggiunte variabili artificiali Come conseguenza otteniamo una continua diminuzione di indice previsionale, ricerche di mercato che portano a target diversi, personaggi e tendenze che emergono in tempi e luoghi inaspettati, previsioni di spesa che vengono superate in misura abnorme (tangenti a parte). Successivamente, per giustificare questi eventi, si presenteranno soluzioni basate unicamente sui risultati, aumentando così l’ambiguità tra realtà e astrazione. Seguendo queste procedure i risultati vengono a sommarsi e sentiamo aumentare lo straniamento di una realtà concreta – di cui necessitiamo – dalle realtà ufficiali e diversificate che siamo costretti a vivere.
Passiamo adesso all’altro elemento che rientra in quell’ordine di base prima accennato, vale a dire il fantastico. Come la realtà oggettiva risulta inquinata e disintegrata in una serie di realtà probabili da parte della componente fantastica, così quest’ultima appare snaturata da ciò che rappresenta la realtà sociale per antonomasia, e cioè la tecnologia. C’è un’altra causa di snaturatezza del fantastico, che è la droga, ma il fenomeno rientra in un aspetto della società il cui esame esula da questo contesto benché non lo si possa non menzionare come forma più eclatante di allontanamento dalla realtà, non però come componente equilibratrice ma, al contrario, come fuga disperata.
In una società di profitti, e quindi di consumi, il fantastico non poteva essere ignorato, il suo campo d’azione essendo troppo vasto. Il risultato è una marea di fantastico di massa che diventa di giorno in giorno più sofisticato fino ad arrivare alla partecipazione concreta in simulazioni elettroniche dove la facoltà di libero arbitrio è altrettanto simulata. È lo stesso processo di appropriamento e contaminazione di ruolo avvenuto per il tempo libero, per quel turismo denominato alternativo, ecologico, intelligente e che invece, nella realtà vera del ritmo frenetico e inflessibile imposto dalle strutture tecnologiche che lo creano, provoca stress e appiattimento cognitivo: un turismo dell’obbligo basato sul numero, quindi non più viaggio di scelta nel senso di iniziativa e momento liberatorio personali ma rito collettivo. Gli Hemingway e i Kerouac – per fermarsi solo all’ieri – con la trepidazione esistenziale on the road sono ormai lontanissimi.
Allora non più viaggio di riflessione, di contemplazione e forse di catarsi, di incontro con il meraviglioso per stabilire un colloquio con il proprio immaginario, perché il turismo dell’obbligo non dà la possibilità di guardare per vedere; anzi, paradossalmente, impone a volte ritmi più ferrei e faticosi di quelli della routine quotidiana.
Contemporaneamente all’esotismo all-inclusive delle agenzie turistiche, ci vengono offerti scenari simulati da computer che lavorano in gigaflop, cioè in miliardi di operazioni al secondo. L’arseniuro di gallio ci fa calcolare in teraflop, cioè in trilioni di operazioni al secondo. I laser dell’ultima generazione (ma forse al momento in cui queste note verranno lette non faranno più parte dell’ultima generazione) inviano impulsi luminosi in femtosecondi, vale a dire in milionesimi di miliardesimi di secondo. Douglas Trumbull ha presentato lo show scan, un sistema di proiezione a 60 fotogrammi al secondo contro i normali 24, con pellicola da 70 mm e 6 piste Dolby, con il quale si ottiene un effetto definito “realtà accresciuta”. Leggo su una rubrica di software: “La Electronic Arts presenta Populous ovvero ‘simulatore di Dio’. Siete un dio e usate qualsiasi mezzo ‘divino’ per accrescere il vostro potere facendovi adorare dal vostro popolo, scatenando terremoti, pestilenze, alluvioni sulla gente del Male. Un po’ di ironia nei confronti di quelli che conoscono a menadito la storia delle religioni. Sulla destra l’indicatore di potenza caricato dalla fede del vostro popolo adorante dà la misura della vostra forza. Prima cosa da fare è piazzare il Magnete Papale dove vi suggerisce la vostra strategia. Il vostro popolo lo seguirà e si moltiplicherà finché sarà talmente forte da partire contro il nemico. Vinto o perso si va avanti. Dopo la Genesi rimangono ancora 999 mondi sui quali cimentare la vostra divinità simulata. Preannunciata una versione Atari. Da non perdere.”
La bionica sta ponendo problemi altrettanto inquietanti di quelli derivati dall’ingegneria genetica. Quando i bio-chip usciranno dalla fase sperimentale (ma non saranno già usciti?) saranno i nostri stessi neuroni a portarci su mondi e dimensioni preparati dalle industrie di software, si creeranno rapporti simbiotici tra schermo TV e spettatore interprete, e si potrà penetrare nello spazio che sta al di là del video e portare a livelli esasperati l’indeterminatezza tra realtà oggettiva e simulazione elettronica.
Le realtà virtuali si stanno allargando a macchia d’olio, già sono apparse “sale interattive” dove gli spettatori diventano protagonisti accompagnati, per ora, da un attore-guida. Già è stato elaborato un programma per computer che consente di fabbricare una sceneggiatura sulla base di modelli precostituiti. I sistemi What you see is what you get cioè “Quello che vedi è ciò che ottieni” offrono con procedimenti interattivi la liberazione della creatività lasciando all’operatore la semplice selezione di ciò che l’elaboratore offre.
Ma a questo punto viene da chiedersi quale creatività soggettiva può esserci nello scegliere tra combinazioni proposte da un software quando è noto che la facoltà immaginativa si sviluppa in misura inversamente proporzionale alla mancanza d’immagine. Ne deriva che il grado di atrofizzazione delle nostre capacità immaginative e fantastiche aumenta a mano a mano che esse vengono sostituite da tecnologie olistiche che subentrano alla rappresentazione del vero, e ci introducono in microcosmi personali fatti di pseudo-realtà indeterminate.
Questi riferimenti dimostrano che, per la prima volta, ci troviamo di fronte a una colonizzazione dell’immaginario di dimensioni globali. Realizzazioni già a disposizione – o che lo saranno tra breve – cominciano a destare sospetti in fasce di fruitori sempre più vaste e, più o meno inconsciamente, vengono allontanate. Chi le accetta con entusiasmo immutato non si rende conto del condizionamento che esse hanno già provocato e che provocheranno nel tempo.
Già ora viviamo nel sovvertimento della logica. È noto che la linea di non ritorno nella società accettata con così grande entusiasmo è già stata superata e i risvolti negativi hanno cominciato ad abbattersi su di noi in forma gestaltica. Tutto ciò provoca senso di nullità, di impotenza, quello stato di instabilità che Kirkegaard definisce “angoscia del possibile”.
Flavio Manieri, psicanalista freudiano di Roma, dice: “Crollano ogni giorno certezze primarie, messe in discussione da una società in rapidissima transizione. L’uomo si avverte assediato.”
Nel maggio del 1988 fu presentato a Tabor, nella ex Cecoslovacchia, durante il 26° Congresso della Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema, la Carta dei Diritti del Pubblico. L’articolo 1 recita: “Il pubblico ha il diritto di ricevere tutte le informazioni ed espressioni audiovisive. Il pubblico deve avere i mezzi per esprimersi e per far conoscere i propri giudizi ed opinioni. Non vi sarà umanizzazione senza comunicazione“. L’articolo 4 dice: “I diritti del pubblico corrispondono alle aspirazioni e alle possibilità d’uno sviluppo generale delle facoltà creative. Le nuove tecnologie devono essere utilizzate per tale obiettivo e non per l’alienazione di massa.”
In previsione di un target europeo di 350 milioni di persone, l’individuo non dovrebbe essere considerato unicamente nella logica dell’audience e come consumatore di prodotti. Questo, ovviamente, nelle intenzioni. Ma sappiamo benissimo quanto difficile sia modificare una società basata sulla logica del profitto concreto. Cesare Romiti, al congresso su Etica e politica alle soglie del XXI secolo disse che “fare profitto non solo è lecito ma è la regola morale fondamentale dell’impresa“. Resta da vedere quali sono i mezzi usati per raggiungere tale fine morale.
Ecco che allora diventa urgente riappropriarsi dello spazio previsto per il nostro fantastico personale, e questo non per mera soluzione escapista, quanto per recuperare, attraverso una giusta misura di esso, una giusta misura della realtà oggettiva che ci è stata tolta. Carlo Sgorlon dice che poiché la nostra epoca è dominata dalla razionalità, soltanto i problemi legittimati dalla ragione e dalla razionalità continuano ad avere il diritto di cittadinanza. Ciò che è legato all’immaginazione, alla favola, alla fantasia, alla magia, all’istinto, all’intuizione, al mistero, al magma confuso e indifferenziato delle origini, ai fatti genetici, agli occhi degli uomini moderni possiede una sorta di vizio di origine che lo squalifica, o quanto meno lo fa guardare con sospetto.
Ma dove sta il nostro fantastico oggi? In un articolo sul Corriere della Sera Enzo Siciliano scriveva che “l’esortazione continua alla gara per la vita edulcorata delle immagini patinate degli spot pubblicitari non può non impoverire la resistenza etica generale“. Si riferiva al male oscuro che ci ha resi insensibili, mitridizzati a forme di criminalità quotidiane facendoci abbassare il metro di giudizio. E ancora: “Siamo rassegnati a non dare più spazio, all’interno di noi stessi, al sentimento della libertà del volere e della responsabilità” in una società che “destruttura l’individuo o che eleva la deregulation a proprio parametro di condotta e che quindi non può non ammalarsi.”
Ovviamente il discorso implica quell’assuefazione non solo alla criminalità per mancanza di giustizia, ma anche a parametri imposti per sostituire spazi intimamente personali e, fra questi, nella dimensione del fantastico, esiste un confine a cui ci siamo avvicinati paurosamente, ci troviamo ormai in un vicolo cieco dal quale difficilmente potremo uscire. Nella nostra società massimediale il grado di indeterminazione per stabilire cos’è e dove si trova il fantastico non solo soggettivo ma anche collettivo che si aggancia alle nostre radici mitiche e simboliche, di costumi e tradizioni, necessario per una qualità equilibrata della vita, aumenta giorno dopo giorno.
Trasmettere un fatto significa far passare questo fatto attraverso uno o più medium. Werner Heisenberg dimostrò che nel momento in cui interveniamo sulla materia per studiarne gli elementi basilari, essi vengono modificati dallo strumento usato, che determina il grado di indeterminazione. Gli strumenti usati oggi per captare la realtà oggettiva e proporla alla massa sono estremamente sofisticati: il risultato è una realtà filtrata attraverso operatori umani ed elettronici i quali aumentano il grado di indeterminazione ricorrendo a scelte arbitrarie, a effetti atti a enfatizzare o sminuire, all’uso di parole per commentare e manipolare. Tutto questo in ottemperanza a ben precisi obblighi politici, sociali, ideologici, spettacolari, alla disponibilità di tempo e di spazio, di finanziamenti, di redditività. Una massima greca dice che vedere dipende in primo luogo dalla posizione dell’occhio.
Applicare al fantastico – o alla realtà al quale esso è legato – il principio di indeterminazione può sembrare azzardato, e forse lo è; ma poiché immaginario e fantastico sono componenti della nostra condizione umana e, come il DNA, determinano le caratteristiche con le quali dobbiamo affrontare il mondo e quindi ci forniscono gli strumenti per interpretarlo, potrebbe non essere così arrischiato farli rientrare in quell’ordine di base dove troviamo concetti come entropia, relatività, freccia del tempo nei sistemi fisici reali. Vediamo infatti che anche la velocità del tempo è agganciata al principio di indeterminazione mediante il cronone secondo la teoria corpuscolare del tempo stesso.
Il parametro su cui il fantastico si realizza è l’insieme di eventi e di materialità che forma il nostro quotidiano quadridimensionale in quanto, per produrre fantastico, dobbiamo lavorare sulla realtà oggettiva: più spazio diamo al pragma, al fatto, al concreto, meno ne resta per il fantastico. Per contro, più usiamo il fantastico per le nostre necessità, più vediamo il quotidiano in una diversa ottica di concretezza. Il fantastico esiste nella natura umana come l’indeterminazione esiste nella materia. Scienza e tecnologia hanno svelato l’importanza dell’indeterminazione dimostrandone le ramificazioni. Parimenti, scienza e tecnologia hanno ampliato la zona periferica della realtà dove il fantastico si confonde con essa. Più sofisticati sono i mezzi per accertare posizione e velocità di una particella, più aumenta la difficoltà di individuarla. Più sofisticata è la tecnologia che regola la nostra esistenza materiale, più si allarga l’indeterminatezza del nostro fantastico soggettivo.
Negli Stati Uniti, area guida dell’attuale civiltà occidentale, i bambini in età compresa tra i 2 e i 12 anni siedono davanti al teleschermo in media 25 ore la settimana, e quando accedono alle scuole superiori hanno trascorso non meno di 15.000 ore davanti al video, cioè 4.000 in più che non a scuola. Nello stesso periodo 350.000 spot pubblicitari saranno passati davanti ai loro occhi.
Una statistica sulla pubblicità in Italia ha calcolato in 600.000 gli spot trasmessi in un anno. Un breve calcolo sulla base di 15 ore quotidiane di trasmissioni fruibili porta a 1,8 spot per minuto, a parte la pubblicità occulta, riflessa, indiretta eccetera.
È così che un corretto sviluppo dell’immaginazione viene neutralizzato in maniera irreversibile, determinando una distorsione della realtà naturale e imponendo necessità sterili e frustranti con danni permanenti nell’inconscio. E la risposta di coloro che ancora convivono con il proprio fantastico naturale, cioè “lasciar lavorare la fantasia”, sarà sempre più incomprensibile. Credo che a questa categoria di persone debba essere demandato un compito: insegnare il fantastico naturale a coloro che ne sono stati privati ovvero non sono più capaci di rintracciarlo, usare grimaldelli ermeneutici per mettere questo prezioso elemento a loro disposizione.
Con l’intrusione della tecnologia nell’immaginario personale, il modo di fantasticare usato per migliaia di anni è stato dissolto in una manciata di lustri, spinto in un angolo, sopraffatto da un immaginario prefabbricato, chiassoso e proteiforme, in un vorticoso processo di partenogenesi elettronica. Allora, per portare il discorso a una sorta di deontologia da parte di chi ha la possibilità di trattare confidenzialmente con il proprio fantastico nei confronti di coloro che pongono domande del tipo “come si fa a immaginare certe cose”, bisogna indicare la strada verso un fantastico nel quale riconosciamo le nostre radici e quindi noi stessi, enucleandolo da un magma di realtà stravolta e di immaginario imposto in cui la sua presenza è obnubilata dallo stato di indeterminazione.
Ogni bambino, ogni giorno, perde un pezzetto del bene più prezioso della sua età: la creatività. Pertanto c’è una rivoluzione da compiere, non tanto nel significato che usualmente diamo al termine, quanto in quello originario di ritorno al fantastico che sta alla periferia della realtà in ognuno di noi, in quella zona limitrofa dove dimensioni “altre” si innestano e sconfinano, per contribuire a trasformare le attuali generazioni dell’immagine in generazioni dell’immaginario, cioè far pensare la gente fuori della TV. Credo che il tramandare la nostra facoltà immaginativa sia un dovere, proprio come lo fu il tramandare le arti e i mestieri, gli usi e costumi che forgiarono le civiltà europee. In società dove la scienza aumenta la durata della vita e contemporaneamente gli anni di attività vengono sempre più ristretti fino a vedere top-model di 14 anni e pensionamenti a 40 anni, dove il welfare state non può mantenere il numero sempre più alto di vecchi e si allarga sempre più la fascia di esistenza angosciosa dovuta all’emarginazione, all’incomunicabilità generazionale, alla mancanza di strutture destinate a elementi non più produttivi in termini di bilancio, è necessario riprendere le nostre misure anche se siamo costretti a vivere in spazi a noi non adatti.
Ovviamente, questo viaggio alla ricerca del fantastico perduto si dirama in varie direzioni: nel quotidiano, nell’ucronicità, fra gli universi antropici che ci affiancano ma verso i quali non sono ammessi passaggi materiali, nelle radici mitiche e leggendarie che contengono la chiave d’interpretazione di tanti comportamenti attuali diventati scorza senza frutto.
Norbert Wiener, il padre della cibernetica, disse che “la continuità con il passato è fatta anche dalla presenza delle case, delle strade, delle fattorie e delle città costruite dalle generazioni passate. Distruggerle o ignorarle sarebbe veramente una morte oltre la morte.” Aggiungiamo, con Victor Hugo, che una città è memoria pietrificata.
La perdita del senso delle proprie tradizioni culturali è peggiore della perdita della libertà. Ci impedisce di avere delle prospettive su cui lavorare, selezionare, costruire, e fa in modo che la tecnologia sia un mero passaggio di spugna su quanto è stato fatto nel passato. I vecchi miti sono crollati ad uno ad uno, ma la loro mancanza – come essenza – si fa sentire. Prendendo ancora a prestito il pensiero di Carlo Sgorlon, sono venuti a mancare i paralleli e i meridiani del nostro vivere, si sono dissolte le palizzate rassicuranti dell’etica, i giroscopi che ci davano stabilità, le bussole che servivano ad orientare l’uomo nel dedalo inestricabile del reale. È vero che nuovi miti si affacciano, però, nella loro caducità, essi perdono valore semantico e trascendentale. La neo-mitopoietica ha creato i mitici anni 50, i mitici 70, i mitici interpreti del rock, moltissimi altri miti sponsorizzati e massificati in un frenetico usa-e-getta in quanto tallonati da nuovi pseudo miti imberbi buoni solo per presentare la Lotteria Italia. Oppure alcuni archetipi vengono ripresi, estratti dal loro habitat storico, allegorico e mitico per essere aggiornati e giudicati con gli occhi di oggi. Dio aveva gradito l’offerta di Abele e non quella di Caino in quanto essi rappresentavano – come precisa Mircea Eliade – l’esistenza semplice e pura dei pastori nomadi contrapposta alla vita sedentaria degli agricoltori e cittadini; ed è sintomatico che oggi Caino sia stato riprocessato e assolto in quanto simbolo di civiltà urbana e quindi di tecnologia.
Ma ci sono alcuni segnali interessanti. Ilya Prigogine ha sintetizzato fisica, chimica e biologia in una concezione neo-rinascimentale che ricolloca l’uomo al centro dell’universo e nega ogni lacerante divisione tra scienza e umanesimo. Per Prigogine la nuova frontiera è la cosmochimica. Egli dice: “Ogni struttura in equilibrio ad un certo punto rompe questo equilibrio e di nuovo dal disordine rinasce una regolazione che determina un’altra struttura. La società modifica il singolo ma il singolo modifica la società. È una continua ricerca di equilibri.”
Possiamo allora vedere un nuovo equilibrio in una rivalutazione dell’uomo secondo la quale, mettendo da parte certi estremismi post-modernisti e pur sottraendo l’essere umano da una visione assoluta e antropocentrica, esso venga posto al centro di un universo antropico, esistente cioè in quanto è l’uomo che si rende conto della sua esistenza.
Oltre a segnali di natura filosofica, ci sono anche altri segnali che riguardano il fantastico in maniera più concreta e la sua interpretazione letteraria. La situazione esposta finora non poteva non creare uno stato di insofferenza in quella parte di autori e di pubblico che ha mantenuto la propria identità, soprattutto in Paesi le cui radici culturali sono ben più profonde di quelle appartenenti a chi ha imposto l’attuale way of life. I modelli che ci vengono presentati come nuove realtà provocano disagio in quanto non in accordo con una realtà basata su valori culturali fatti diventare repentinamente obsoleti, aiutati in questo anche dalla “lungimiranza” di certi nostri uomini politici con la ricorrente criminale intenzione di abolire dalle scuole materie umanistiche.
E allora non ci resta che cercare profondamente in noi stessi per il recupero di un equilibrio al quale ancorarsi in questo magma di indeterminazione, per una ricerca di identità a cui aggrapparsi, per non soffocare nell’angoscia. In quest’ultimo decennio abbiamo assistito a un risveglio della letteratura fantastica per la quale il mainstream non aveva avuto certamente occhi di riguardo, e a un’esplosione della fantasy nell’editoria specializzata. Si potrebbe facilmente far risalire questo interesse all’azione poderosa e trainante delle due opere che hanno scosso i rispettivi campi, e cioè Il nome della rosa e Il signore degli anelli; ma già c’erano fermenti, e queste due opere hanno coagulato intorno a sé l’ancora sparsa ma imperiosa necessità di fantastico, la necessità di riappropriarsi di una componente che ci era stata rubata e imbastardita, la rabbia nel vedere morire una parte di noi.
In copertina foto: Getty Images
Renato Pestriniero
Renato Pestriniero, veneziano, sposato, una figlia. Fino al 1988 capo reparto presso la filiale veneziana di multinazionale svizzera. Dal suo racconto “Una notte di 21 ore” il regista Mario Bava ha tratto il film “Terrore nello spazio.” Esperienze televisive, radiofoniche, fotografiche e figurative.