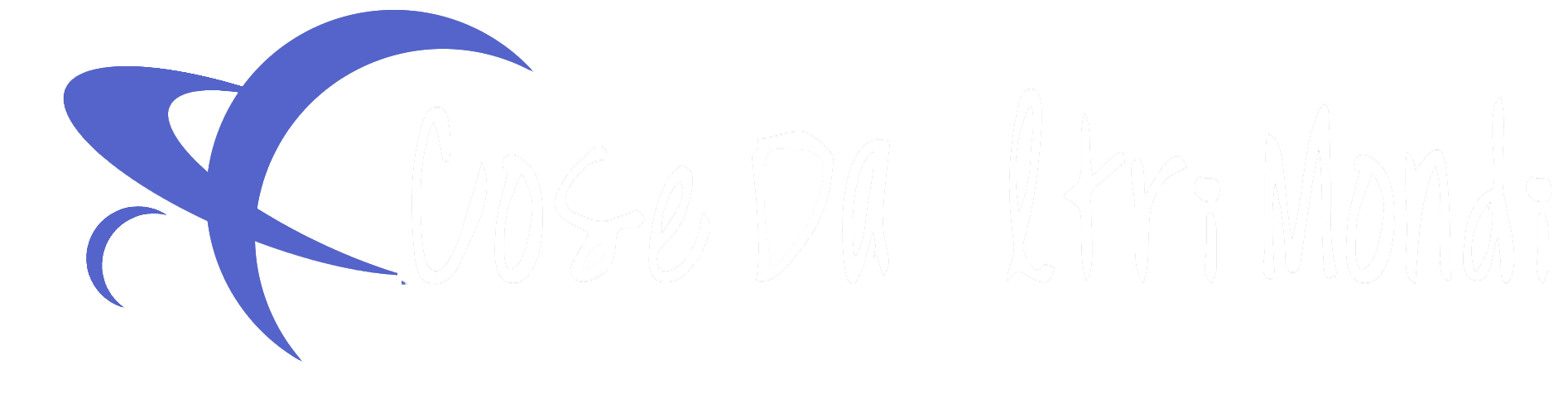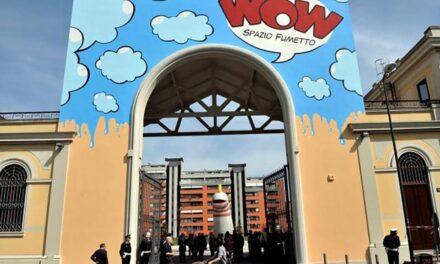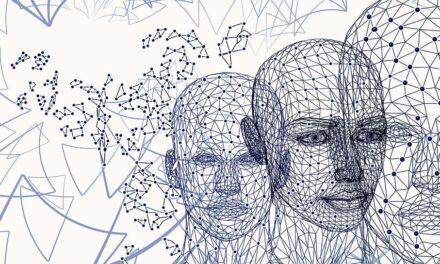L’UOMO NELLA FANTASCIENZA

A circa sessant’anni dalla nascita della science fiction, abbiamo la possibilità di ottenere una visione d’insieme. La prospettiva del tempo evidenzia e schematizza i periodi che hanno caratterizzato questo genere di letteratura e ne fa risaltare le grandi linee di trasformazione; all’interno di esse si intravedono le tracce delle ramificazioni minori, i tentativi appena abbozzati, le intenzioni rimaste tali.
Quando nel 1926 Hugo Gernsback dava inizio al genere inquadrando in pubblicazione periodica le visioni di Verne, Poe e Wells, è noto che la preoccupazione maggiore era quella di esaltare la macchina lasciando in ombra, se non nell’oscurità completa, la componente psicologica dei personaggi.
Con Astounding Stories di Harry Bates l’oscurità psicologica si attenuò ma la caratterizzazione dei personaggi rimaneva appena tracciata e comunque stretta dentro i confini dello stereotipo.
Fu solo negli anni ’50 che vennero trattati problemi identificabili con quelli di tutti i giorni: per la prima volta ci si accorgeva dell’uomo e delle sue reazioni di fronte a una società ostile, un uomo costretto a combattere non tanto contro alieni orripilanti quanto contro gli effetti che la scelta tecnologica provocava o avrebbe provocato.
Poiché la science fiction non rientra nel concetto di immutabilità proposto dai creazionisti, si assisteva ai primi salti di qualità: essa cominciava a trasformarsi dando così inizio al proprio ciclo evolutivo. E continuando nella strada dell’evoluzione, negli anni ’60 si sviluppò la New Wave attraverso la quale, in un processo di esasperata reazione, ci fu uno spostamento in aree introspettive talmente sofisticate da raggiungere a volte l’ermetismo. Nell’impegno di staccarsi dalle arene sconfinate dello spazio esterno, questo movimento esplorò le regioni altrettanto vaste e misteriose dello spazio interno.
Ma, come spesso succede, la reazione a un estremo porta all’estremo opposto. E il progetto lodevole di dare smalto a una letteratura già in via di nobilitazione, si autoeliminava per troppa complessità e ambiguità di stile. Il movimento peccò per eccesso ma lasciò il segno. Ed è molto importante il fatto che, con la New Wave, ci sia stato il primo tentativo “made in Europe” di sganciamento della science fiction dalla canonicità delle sue origini e che questo sganciamento sia avvenuto attraverso una presa di coscienza in quell’area rimasta fino ad allora emarginata e cioè la sfera dell’uomo con il sue spessore psicologico, la sua interiorità di fronte al presente e al futuro, le angosce dovute alle esasperate trasformazioni della società alle quali gli risulta sempre più difficile conformarsi o non vuole farlo, consciamente o inconsciamente. Anche se fu calcata un po’ troppo la mano, quel movimento evolutivo squarciò il muro che impediva all’uomo di essere, nella science fiction, uno dei veri protagonisti.
Esaminando il problema dal nostro osservatorio attuale, siamo in grado di scorgere: una space opera in cui l’uomo non esiste se non come mera presenza fisica, una science fiction tecnologica e sociologica in cui è maggior rispetto per la posizione esistenziale dell’uomo e maggiore rigore formale, una New Wave dall’introspezione esasperata, una spostamento verso la fantasy per un recupero dell’immaginazione allo stato puro e un recupero di miti ancestrali. Tutti rami di uno stesso tronco sviluppati o atrofizzati per obbedire a necessità di equilibrio.
A questo punto il mio pensiero va al naturalista francese Jean-Baptiste Lamarck. La sua teoria sull’evoluzione mi ha fatto scorgere un parallelismo con il genere letterario che ci interessa. Lamarck vedeva l’evoluzione della specie non tanto negli schemi darwiniani di una selezione naturale attraverso modificazioni casuali che permettevano ai migliori di sopravvivere in un mondo sovraffollato, quanto nello sviluppo e nell’involuzione di organi a seguito di mutamenti di bisogni causati dall’ambiente.
Il parallelismo appare evidente osservando i tentativi sperimentati dalla science fiction per arrivare a un equilibrio di concetto e di forma tale da mantenerne la presenza e permetterne il consolidamento. Ritengo che l’esigenza di un modello europeo si sia maturata nell’ambito di questo processo di evoluzione lamarckiana malgrado ci sia ancora una notevole tendenza a seguire modelli nei confronti dei quali difficilmente potremmo essere competitivi; eppure anche la nuova generazione di scrittori americani ha sentito la necessità di avvicinarsi maggiormente all’uomo indagandone la personalità in sfaccettature fino a poco fa impensabili. Ho avuto modo di conoscere personalmente un valido rappresentante di questa generazione di scrittori che abbiamo oggi qui con noi, Kim Stanley Robinson.
Nella presentazione della versione italiana del suo Icehenge, Piergiorgio Nicolazzini mette in rilievo “la prosa elegante e meditativa, la caratterizzazione, le relazioni dei personaggi con l’ambiente, la coscienza, il tempo, la storia, l’impiego delle convenzioni fantascientifiche mediate da una grande sensibilità letteraria, la sottile analisi psicologica.” Viene inoltre sottolineato che Kim Stanley Robinson “dà il meglio di sé nelle descrizioni dell’uomo a confronto con l’ambiente naturale: un’esperienza che è sempre il riflesso di un percorso interiore.”
Fino a non molto tempo fa queste parole sarebbero state usate per presentare opere appartenenti a una corrente umanistica europea più che a lavori provenienti dalla patria della tecnologia e della hard science fiction. Quindi, e a maggior ragione, se vogliamo stabilire un dialogo che non sia solo occasionale, dobbiamo percorrere strade a noi congeniali, aderenti al nostro retaggio culturale e umanistico; dobbiamo accantonare il concetto creazionista di science fiction come sinonimo riduttivo di azione, suspence e meraviglia ad ogni costo, e sviluppare una simbiosi tra la freschezza di questo genere letterario e il rigore del mainstream, attingendo alle componenti antropologiche, nobilitando la presenza dell’uomo nell’approfondimento delle sue problematiche, calibrandone lo spessore nel ricordo delle esperienze passate, rivalutare le nostre origini culturali senza dimenticare, ove possibile, quel bagaglio di leggende, usi e costumi e tradizioni più o meno fantastiche di cui in Europa esistono fonti inesauribili. Eliminando così estremismi macroscopici e sviluppando componenti lasciate in ombra, ma a mio parere indispensabili, verrebbe data ulteriore spinta per consolidare una fisionomia letteraria in equilibrio e maturità.
Quando mi fu proposto di sviluppare in romanzo il racconto di A.E.Van Vogt The Enchanted Village accettai con grande entusiasmo non solo per il fatto di poter lavorare sull’opera di uno dei grandi nomi della science fiction mondiale, ma anche perché mi trovai di fronte alla possibilità di usare componenti italiane di introspezione e contenuto su una matrice americana. Affrontai quindi la prima di quelle che alla fine dovevano diventare 259 cartelle con l’entusiasmo della sperimentazione: trasformare The Enchanted Village nell’ottica di un’evoluzione lamarckiana, conformandomi per colore e azione allo stile dell’autore canadese ponendo però l’accento sulla presenza dell’uomo, cercando di calibrare il ritmo e i rovesciamenti di situazioni tipici di Van Vogt con parentesi analitiche e con plausibilità di azione, amalgamando l’estro e il senso del meraviglioso con la credibilità e lo spessore psicologico dei personaggi.
Chi ha letto il racconto ricorderà che in esso viene descritta la lenta trasformazione di un uomo; Jenner, il protagonista, si trasforma in marziano senza accorgersene, anzi, pensa di aver sconfitto il villaggio mentre è quest’ultimo che ha trasformato lui.
Il villaggio mi si è subito presentato come simbolo del persuasore occulto che provoca in Jenner – e in tutti noi – una metamorfosi esteriore e di comportamento che non arriva però alla profondità dell’essere e suscita sfasamento, malessere, crisi d’identità e dubbio su chi siamo veramente, quel sentirsi diversi da ciò che ci hanno fatto diventare, cioè particelle di un uomo-massa che devono seguire i trend imposti in misura sempre più pressante e fino a livelli sempre più intimi quali il sesso e il diritto alla fantasia.
E così ho usato il concetto di trasformazione come fulcro per sviluppare uno dei temi che più mi affascinano, quello appunto dei persuasori occulti, la ristretta casta di programmatori che ci manovrano con la mistificazione della propaganda politica, economica, sociale e religiosa, dell’immaginario personale e del comportamento, dei canoni di pensiero e della scala dei valori, in altre parole un discorso sul libero arbitrio che ho trattato anche nei due romanzi Le torri dell’Eden e Perigeo.
Ho accennato al diritto alla fantasia. Credo che il perdurante sviluppo del filone fantasy non sia dovuto solo a quello che viene definito “effetto Tolkien” ma anche all’incasellamento delle nostre esistenze e dei nostri modi di pensare causato da strutture sociali che presentano soluzioni prefabbricate per qualsiasi necessità, inclusi gli scenari del fantastico, nonché al disincanto per ciò che il progresso tecnologico aveva promesso.
Nell’analisi dello stress derivato dalla necessità di mantenere l’adeguamento psicofisico imposto dal progresso tecnologico, ci troviamo di fronte all’angoscia nucleare, alla limitatezza delle nostre facoltà percettive nello sviluppo di concetti quali spazio e tempo e quindi alla consapevolezza del nostro inserimento in un contesto cosmico che si rivela sempre più come un gioco di scatole cinesi. E, ancora, al sospetto di essere personaggi eterodiretti, alla pubblicità come sistema di sopravvivenza, agli interrogativi filosofici, religiosi, umani e sociali che l’ingegneria genetica ci sta ponendo con la manipolazione del DNA, all’annullamento del libero arbitrio attraverso mezzi estremamente sofisticati perpetrato dagli onnipresenti ma invisibili image-makers e opinion-makers.
Molte soluzioni già realizzate o che sicuramente si realizzeranno ci fanno paura, e più o meno inconsciamente le rifiutiamo. Oppure le accettiamo senza però renderci conto pienamente del condizionamento che esse ci provocheranno nel tempo. Da un lato ci si presenta un futuro tecnologico di cui abbiamo superato il punto di non-ritorno – e i singoli risvolti negativi si stanno sommando e cominciano a ripercuotersi su di noi in forma gestaltica – dall’altro lato sentiamo crescere un’insicurezza globale, un senso di nullità e di impotenza, abbiamo la sensazione di correre verso un baratro, soggiogati da quello stato d’animo di instabilità che in Kierkegaard troviamo come angoscia del possibile. Ogni mattina, sulle pagine dei giornali, assistiamo al sovvertimento della logica, e con inquietudine sempre maggiore chiediamo a noi stessi verifiche sulla nostra posizione esistenziale.
Ecco allora il bisogno di una lettura del mondo in chiave umanistico-fantastica.
Di fronte a questo bisogno, alcuni anni or sono mi resi conto di trovarmi in una situazione privilegiata per proporre una lettura in tale chiave. Io vivo a Venezia, dove sono nato e cresciuto, e sentii che dovevo far conoscere l’aspetto “altro” di questa città costruita con la pietra ma anche con l’acqua e la nebbia e il silenzio, portandola come simbolo di tutto ciò che l’uomo sta perdendo non solo materialmente ma soprattutto nella capacità di guardare al di là degli scenari imposti.
Nel 1985 venne pubblicato il mio racconto La nave di pietra, ed era l’inizio di un discorso che sto ancora portando avanti, usando la genetica come scatenamento delle visioni ipnagogiche, e Venezia – dove lo “straordinario” è regola di vita – come materializzazione dell’immaginario e dell’archetipo junghiano.
Esiste un gemellaggio tra Venezia e Montpellier, e probabilmente questa opportunità avrà dato modo a qualcuno di conoscere più in dettaglio la genesi della Serenissima e come essa non poteva non racchiudere in sé componenti misterico-fantastiche tali da collocarla su una dimensione al di là del concreto, alla quale è impossibile accedere senza chiavi di interpretazione adatte.
Per denunciare i danni provocati alla componente umanistica da parte del pensiero tecnologico di massa, ecco che Venezia offre un palcoscenico già predisposto in una dimensione alternativa. La possibilità di raggiungere questa dimensione è a disposizione di tutti coloro che sono abbastanza curiosi da trovare le smagliature dissimulate nel concreto intorno a noi in molti luoghi in Europa, e passarvi attraverso. Abbiamo ancora molte “città dell’uomo”, e poiché la science fiction ha bisogna dell’uomo per imporsi come unica letteratura valida, dobbiamo usare il materiale rimasto a nostra disposizione finché siamo in tempo. Sta a noi usarlo al meglio.
Ottobre 1987
In copertina: Il “futuro della radio” secondo Hugo Gernsback, by Medium Italia
Renato Pestriniero
Renato Pestriniero, veneziano, sposato, una figlia. Fino al 1988 capo reparto presso la filiale veneziana di multinazionale svizzera. Dal suo racconto “Una notte di 21 ore” il regista Mario Bava ha tratto il film “Terrore nello spazio.” Esperienze televisive, radiofoniche, fotografiche e figurative.