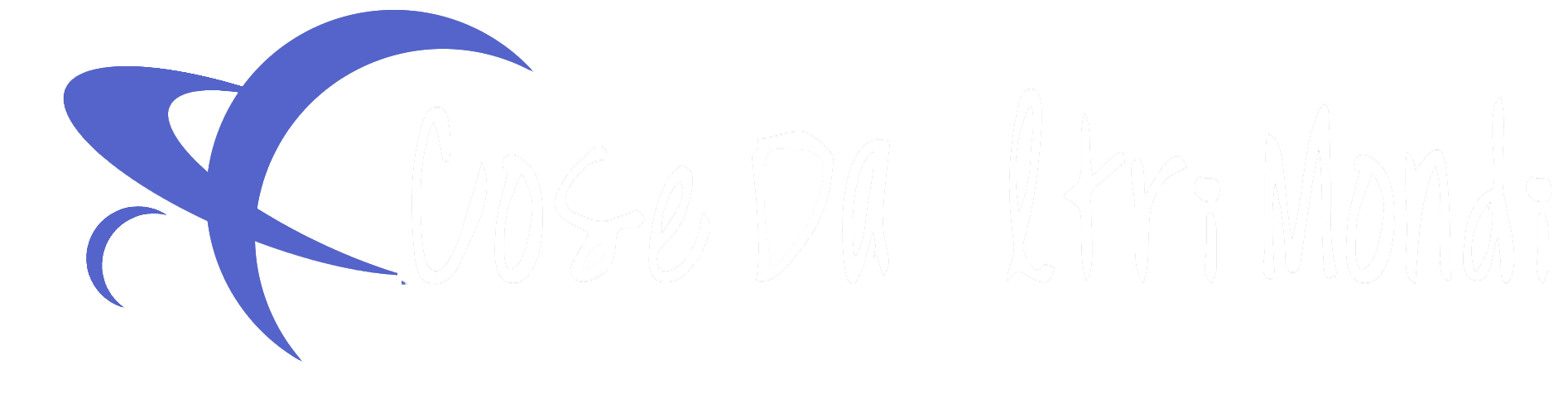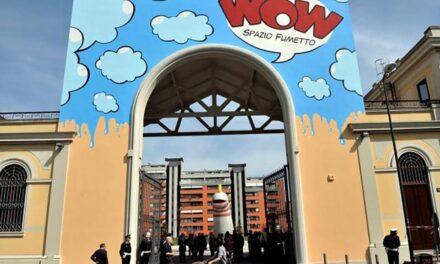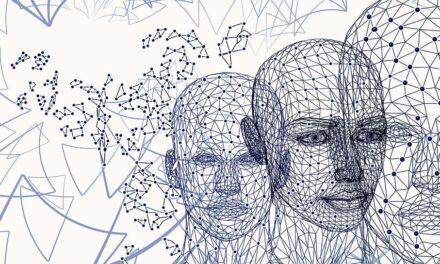“IL TESCHIO” DI HAROLD WARD

Mondi Passati – Vintage
(The Skull, Weird Tales, marzo 1923)
I.
Kimball alzò la mano in segno di monito.
“Ascolta!” esclamò in un sussurro.
Poi spinse la bottiglia con il gomito e afferrò il suo revolver, appoggiato proprio sopra il tavolo. Allacciandosi la cintura attorno alla vita, corse verso la porta e la spalancò.
La casa, eretta su fondamenta profonde cinque metri, tremò sotto il calpestio degli uomini in fuga. Con l’agilità di un animale selvaggio, si accucciò per lanciarsi – e atterrò proprio a cavalcioni sulla schiena dell’ultimo degli indigeni neri in fuga. Il peso dell’uomo bianco spinse l’indigeno a terra. Afferrando il nero per i capelli, lo spinse ai suoi piedi, trattenendo il suo corpo nudo a metà fra se stesso e la folla che indugiava nel buio, appena al di là dell’anello di luce che filtrava dalla porta aperta.
“Qual è il nome?” domandò nel dialetto delle Isole. “Chi di voi ha avuto l’idea di disturbare la casa del padrone? Te lo tiro fuori a botte!”
Sempre afferrando i capelli crespi dell’uomo con la mano sinistra, la sua destra scattò con un tremendo pugno sulla bocca dell’indigeno. L’uomo, sputando sangue e denti rotti, si contorse dal dolore e tentò di lanciare uno sguardo di traverso ai suoi compagni. Vedendo che nessuno si muoveva per aiutarlo, contorse la testa sforzandosi di scappare. L’uomo bianco lo fermò con un altro pugno.
“Qual è il nome?” domandò di nuovo.
“Io brav’uomo,” rispose l’uomo nero con uno sforzo. “Io amico dei missionari!”
“Allora di’ in fretta qualche preghiera!”
Kimball tempestò la sua faccia di pugni su pugni. Il nativo gridava dal dolore. Nell’ombra, i neri si agitavano, come una mandria pronta alla rincorsa, ma il bianco non dava loro nessuna attenzione.
Alla fine, completata la punizione, strappò l’arco e le freccie dalla mano inerme della sua vittima e, girandolo di colpo, gli tirò un calcio che lo mandò a quattro zampe in mezzo agli altri. Poi si girò, come se ignorasse del tutto gli altri nativi, e rientrò nella casa.
Gettando l’arco e le frecce sul tavolo, si versò un robusto bicchiere di gin e lo scolò in un sorso. E poi, sedendosi a lato del tavolo, prese quelle armi e le esaminò attentamente.
“Avvelenate!” fece notare casualmente all’uomo sdraiato sul letto. “Leverò l’anima a Tulagi e sarà una lezione per tutti quanti. Stanno diventando insolenti e c’è solo uno a tenerli a bada. Spero che ti rimetti in piedi presto.”
“Sulla piattaforma, eh?” chiese l’uomo malato svogliatamente.
Kimball annuì.
“Alzano la cresta,” disse seccamente. “Cinquecento negri sono troppi da tenere a bada per uno solo. S’è scatenato l’inferno da quando sei arrivato – allora il cane ha cominciato a mordere il padrone. Quando Donaldson arriverà settimana prossima con lo Scary-Saray, dovremo mandare un nuovo cacciatore di negri. Chisin ne sta addestrando un paio di nuovi giù a Berande.”
L’uomo malato si agitò con un grugnito. “È’ una fortuna che mi sia ammalato!” affermò con amarezza. “Lo sa Dio quanto è dura, ma mi ha dato modo di capire che razza di bastardo tu sia, Kimball.”
Kimball lo guardò torvo. Aprì a metà la bocca come per rispondere. Poi, ripensandoci, si versò un altro bicchiere e riprese a esaminare l’arma che aveva tolto all’indigeno. Si agitò un poco sulla sedia per effetto del liquore che stava bevendo, ma la sua voce era ferma, quando, dopo un minuto di silenzio, si rivolse all’altro.
“Non puoi piantarla, Hansen?”, ribatté. “Ne ho le scatole piene.”
Hansen si sollevò su un gomito e agitò rabbiosamente un pugno verso l’altro.
“Oh, ne hai le scatole piene, vero?” scimmiottò. “E fai bene! Suppongo che sto urtando la tua delicata sensibilità a ricordartelo, eh? Non è qualcosa da urlare ai quattro venti, vero? – scoprire che quello che credevi il tuo migliore amico è un farabutto del genere!”
Kimball si versò un altro sorso. La sua mano tremava un po’ mentre portava il bicchiere alle labbra.
“Oh, non pensarci e dormi!” grugnì.
“Sì, ‘non pensarci’, razza di infido, bugiardo, doppiogiochista! Sarei capace di non pensarci che hai scritto a Gladys per dirle che avevo preso una moglie nera! La volevi tu, non è vero, ubriacone topo di fogna?! È stato solo un colpo di fortuna che mi sono ammalato e tu hai dovuto badare da solo alla piantagione, invece di prendere la posta l’ultima volta,altrimenti non avrei mai ricevuto la sua lettera dove mi spiegava perché mi aveva lasciato.”
“Ti ripeto per l’ultima volta che non le ho scritto io quella roba!” ringhiò Kimball. “Ti sto dicendo che è una bugia. Ti ho mostrato la lettera che le ho scritto, dandoti la mia parola d’onore che qualcun altro t’ha fatto quella sporca!”
“Chi altri qui sulle Isole sapeva che lei era tornata a casa?” domandò Hansen, appoggiandosi sul cuscino di nuovo. “E chi altri sapeva che eravamo fidanzati?”
“E io che diavolo ne so?” rispose Kimball aspramente, afferrando la bottiglia con mano incerta. “Se tu non fossi malato, te le suonerei per come ti rivolgi a me.”
L’uomo malato si alzò ancora sui cuscini, con una smorfia di rabbia, il viso rosso, gli occhi scintillanti di febbre.
“È una strada lunga e diritta!” mormorò. “Sono miei i soldi messi nella piantagione. Kimball – i miei soldi contro la tua esperienza. E punta quella dannata freccia dall’altra parte, stupido! Sei ubriaco, troppo ubriaco per giocare con le frecce. Potresti anche colpirmi da un momento all’altro. Se lo fai, ti verrò a prendere, dovessi farlo persino dalla tomba! E ricordati questo, Kimball: presto sarò in piedi di nuovo, e sistemeremo le cose. E te ne andrai dalla piantagione, tu…”
Se sia stato un incidente o un delitto premeditato, non si sa. Kimball era ubriaco – e di brutto anche. La freccia era carica nell’arco e scattò fra le sue dita tremolanti, la corda tesa. E Hansen lo aveva infastidito, stuzzicato, provocato, insultato. Ad ogni buon conto, quando lui s’accasciò in avanti sulla sedia, la corda dell’arco scivolò fra il pollice e l’indice, e…
Hansen cadde all’indietro sui cuscini con un grido smorzato, la freccia conficcata nella tempia.
II.
Era passata la mezzanotte quando Kimball si svegliò dal suo torpore alcolico.
Per un istante non ebbe alcun ricordo di quel che era successo. La lampada a olio bruciava ancora luminosa, evidenziando la figura dell’uomo sul letto in netto rilievo. Kimball si alzò in punta di piedi per non svegliare Hansen. Il suo piede toccò l’arco steso sul pavimento. Poi gli giunse un flusso di consapevolezza. Di colpo si ricordò di essere un omicida.
Se avesse ucciso Hansen di proposito o no, era incapace di ricordarlo. La sua memoria si era spenta nel preciso momento in cui era crollato in avanti, il suo cervello stanco era ottenebrato dal liquore che aveva consumato nella serata. Sapeva che avevano litigato – che Hansen era stato più molesto del solito e lo aveva insultato.
Camminò verso il letto. Un solo sguardo al volto rigonfio, già nerastro – agli occhi vitrei che lo fissavano di rimando – gli disse che la sua supposizione era esatta: la freccia era stata imbevuta nel veleno. Rabbrividì, mentre spingeva in fondo al tavolo le frecce rimaste che aveva tolto a Tulagi, e si versò un altro bicchiere.
Doveva agire subito. Donaldson e lo Scary-Saray sarebbero arrivati nel giro di pochi giorni. E Donaldson non era uno stupido. Neanche Svensen, il suo aiutante. Entrambi sapevano che non correva buon sangue fra i due soci. E se uno dei domestici avesse trovato il corpo al mattino, avrebbe causato chiacchiere a non finire fra gli indigeni. Qualcuno di loro avrebbe di certo parlato a Donaldson. Il mercante avrebbe senz’altro fatto due più due, e avrebbe riferito i suoi sospetti alle autorità.
Alzatosi, mise a posto il revolver, si allacciò la cintura in vita, camminò in punta di piedi fino alla porta. La pioggia cadeva torrenziale, e il suono dell’acqua rimbombava con forza. Il cielo era screziato dai fulmini, mentre i tuoni rombavano e brontolavano.
Era una tipica tempesta isolana; sapeva che sarebbe durata poco. Eppure, finché fosse durata, gli scuri sarebbero stati tirati, isolandolo da sguardi curiosi se avesse agito subito.
Ma la paura – paura neanche lui sapeva di cosa – lo spinse a spostare gli scuri quel tanto da assicurarsi che non ci fosse alcune luce accesa in vista.
Poi, facendosi coraggio con un altro sorso dalla bottiglia, abbassò la lampada fino a che la stanza non fu in semi-oscurità. Ancora, avanzò verso la porta e , tenendola aperta pochi centimetri, ascoltò.
Soddisfatto, ritornò al letto e raccolse il corpo di Hansen e se lo buttò sulle spalle con grande fatica. Mentre passava davanti al tavolo spense la lampada con un solo soffio.
Poi cercò la porta, tastando attentamente con il piede per paura di colpire qualche mobile nel buio.
Piegando il corpo contro la forza del vento, guadagnò i gradini e aggirò l’angolo della casa che era di fronte agli alloggi dei nativi. Al limitare del boschetto di cocco, si fermò di nuovo per ascoltare.
Dalla alloggi dei nativi non veniva alcun suono. Subito dopo, sfidando il vento, caracollò per mezzo chilometro dentro il boschetto.
Soddisfatto di essere abbastanza lontano dalla casa, lasciò cadere a terra la sua macabra soma e si voltò. La tempesta avrebbe cancellato le tracce prima del mattino. Con la luce del giorno, avrebbe dato l’allarme, come se avesse appena scoperto l’assenza di Hansen.
Durante quel tragitto aveva già pensato a tutto un piano. Sarebbe stato facile rifilare la sua storia alle menti semplici degli indigeni. Avrebbe detto che l’uomo malato si era alzato di notte e s’era messo a vagabondare. Le febbri sono frequenti nelle Isole: e anche il delirio. E, quando il corpo fosse stato trovato con la freccia nel cranio, avrebbero creduto che il loro padrone era caduto vittima di qualche brigante di passaggio.
C’erano in giro una mezza dozzina di fuggiaschi – disertori delle piantagioni – che si nascondevano nella boscaglia, timorosi di salire sulle colline per paura dei feroci uomini delle colline e, allo stesso tempo, timorosi della sicura punizione che gli sarebbe stata riservata al loro ritorno alla piantagione. Uno di loro sarebbe stato incolpato della morte di Hansen. I nativi avrebbero confermato una storia così, quando lui l’avesse raccontata a Donaldson e Svensen, dopo il loro arrivo.
Aveva appena cominciato a tornare verso casa, la testa piegata, assorta nei pensieri, quando un fruscio fra le palme alla sua destra lo spinse a voltarsi di colpo. Mentre lo faceva, una lancia gli sibilò accanto alla testa, conficcandosi nell’albero di fianco. Girò su se stesso e mise mano alla pistola, svuotando il caricatore nella direzione da cui la lancia era arrivata. Era troppo buio per prendere la mira; e un istante dopo un lampo gli mostrò una figura nuda che oscillava dietro un albero in lontananza. Troppo tardi si ricordò che aveva lasciato a casa il caricatore di scorta. Disarmato, si mise a correre, barcollando qua e là tra le lunghe file di alberi fino a raggiunse il limitare del boschetto.
Gli indigeni stavano già sciamando fuori dai loro alloggi, vociando forte.
“Ornburi!” gridò a uno degli uomini. “Di’ ai tuoi compagni che il loro padrone malato è scappato via. Aveva il diavolo in corpo. Io vado dietro a lui. Io incontrato uomo nero cattivo. Uomo nero forse ha ucciso. Andare voi a vedere. Prendere uomo nero, e avrere tanto kai-kai al mattino, niente lavoro, tanto tabacco – tanto di tutto!”
Quando Ornburi partì, fiero di essere stato scelto in mezzo ai suoi compagni, e spiegò agli ultimi arrivati cos’era successo, Kimball risalì i gradini ed entrò in casa. Tornando un istante dopo con un fucile e una bandoliera di cartucce, trovò gli indigeni che si armavano con le loro armi tipiche, strillando e vociando la loro eccitazione alla prospettiva della caccia all’uomo e della festa in caso di successo.
Nonostante i loro sforzi di mantenere una parvenza di ordine, assistiti dall’esuberante Ornburi, era quasi l’alba quando la spedizione fu pronta a partire. La pioggia era quasi terminata, ma a Kimball bastò un’occhiata per capire che il rovescio aveva completato spazzato via le tracce che aveva lasciato. Spostandosi qua e là in mezzo agli alberi, esasperatamente all’erta dei loro nemici nascosti, ci volle quasi un’ora per coprire la distanza che Kimball, col suo peso, aveva coperto in 20 minuti.
Il corpo di Hansen si trovava là dove lo aveva lasciato.
Ma la testa era stata staccata!
III.
Nella sua mente, Kimball non aveva dubbi sull’identità dell’indigeno che gli aveva scagliato la lancia nel buio, perché un controllo fra i lavoranti aveva stabilito che mancava Tulagi.
Risentito dalle percosse che gli aveva dato Kimball, il nativo erano scappato. Nascosto nel buio, accumulando rabbia, il destino gli aveva fatto incontrare l’uomo che lo aveva frustato. Lo stesso destino aveva fatto sì che lui sbagliasse il bersaglio quando aveva scagliato la lancia.
E Tulagi era di una tribù che raccoglieva teste come souvenir.
Con l’arrivo di Donaldson e Svensen nello Scary-Saray, tre giorni dopo, che gli diedero la solidarietà bianca di cui aveva bisogno nel mantenere l’ordine nella piantagione, Kimball riprese la ricerca del fuggitivo. Tulagi, libero, sarebbe stato una minaccia costante, non solo per la sua sicurezza, ma per la pace e la quiete fra gli indigeni. Il fuggiasco era un uomo di grande influenza fra gli altri, e c’era già troppo malcontento fra i lavoratori per permettere l’aggiunta di altri problemi.
Il corpo dell’assassinato Hansen aveva avuto decente sepoltura vicino al limitare del boschetto di cocco, sotto la direzione di Kimball.
Mai per un momento Donaldson e Svensen dubitarono della sua storia, che fu corroborata da Ornburi e dagli altri indigeni. Cose del genere non erano insolite nelle Isole. Entrambi si offrirono di aiutarlo nella caccia al presunto assassino. Perché la supremazia dell’uomo bianco doveva essere mantenuta per il bene comune di tutti.
Fu verso la fine del secondo giorno che trovarono quello che stavano cercando. A fianco di uno scheletro giaceva una testa, la punta di una freccia infilata nella tempia. Un grande formicaio lì vicino raccontava una macabra vicenda.
Che uno dei proiettili di Kimball avesse trovato il suo bersaglio, non c’era dubbio. Tulagi, ferito quasi a morte, era comunque riuscito a portare con sé il suo spaventoso souvenir, per poi farsi strada fino alle colline come meglio poté.
Stremato dalla perdita di sangue, era crollato, per cadere vittima delle formiche.
IV
Mentre i tre uomini bianchi si facevano strada verso la radura, la vista di una goletta ancorata vicino allo Scary-Saray attrasse il loro sguardo. Trascinata sulla spiaggia, vicino alla casa, c’era una barca a remi.
“A prima vista, dev’essere la Dolphin del capitano Grant di Malatita,” affermò Donaldson, coprendosi gli occhi per ripararli dal bagliore del sole. “Non sapevo che si fosse spinta fin quì
Chissà se c’è anche sua figlia con lui. L’hai mai vista, Kimball? È uno schianto!”
Prima che Kimball potesse replicare, camminando poco dietro gli altri e con il teschio, un uomo e una donna uscirono dalla casa per andar loro incontro. Donaldson si voltò di scatto.
“È lei!” esclamò. “La più bella ragazza sulle Isole! Nascondi quel dannato teschio, Kimball! Non è uno spettacolo degno di una donna di quel tipo.”
Erano a un centinaio di metri e la ragazza agitava un fazzoletto verso di loro.
“È strano che lei non sia rimasto a casa per accogliere i tuoi ospiti, Karl!” gridò lei. “E Fred Hansen, dov’è?”
Kimball si portò davanti agli altri.
“Gladys!” esclamò.
“Nascondi quel dannato teschio, ti ho detto!” ringhiò Donaldson sottovoce.
Erano quasi assieme ormai. Kimball infilò il teschio sotto la giacca. Così facendo, l’oggetto quasi gli cadde dalle mani e, nello sforzo di tenerlo, le dita scivolarono dentro una delle orbite vuote.
La punta della freccia, sbucando dall’osso, gli graffiò la pelle. Per un attimo dimenticò la felicità di incontrare la donna che amava.
“Papà voleva fare un viaggio commerciale lungo la rotta, e mi ha portato per tenergli compagnia,” stava dicendo lei, mentre lui si fermava per stringere la mano tesa di lei. “Si direbbe che sei sorpreso di vedermi.”
Prima che lei potesse raggiungerlo, le sue sue gambe cedettero e lui cadde in avanti. Il teschio, cadendo da sotto la giacca, rotolò e rimbalzò una decina di metri più in là, fino ai piedi di un piccolo poggio.
Corsero tutti per prenderlo mentre lui cadeva. Ma troppo tardi. Con un grosso sforzo si mise sulle ginocchia.
“Hansen!” gridò. “Io l’ho ucciso! Giurò che avrebbe saldato i conti, e l’ha fatto! Quella -maledetta – cosa – era avvelenata!”
Piombò in avanti sulla faccia.
Ai piedi del poggio il teschio sorrideva sardonico.
Mario Luca Moretti
Altri interessi oltre al cinema e alla letteratura SF, sono il cinema e la la letteratura tout-court, la musica e la storia. È laureato in Lingue (inglese e tedesco) e lavora presso l'aeroporto di Linate. Abita in provincia di Milano